Cosimo Quaranta è un giovane teologo e filosofo già docente di Teologia di Popolo all’ISSR Ecclesia Mater. Ha recentemente pubblicato presso Queriniana Teologia nella postumanità – Prospettive di dialogo con i post- e trans-umanesimi del presente e su questo libro Trascendente Digitale gli ha rivolto alcune domande.
1. Caro Cosimo, hai pubblicato qualche mese fa per i tipi della Queriniana Teologia nella Postumanità. Prospettive di dialogo con i post- e trans-umanesimi del presente, un libro assai corposo e articolato di cui qui abbiamo qualche pagina
Ci puoi tratteggiare il percorso che ti ha portato a questo studio? E quali sono stati i tuoi punti di riferimento fondamentali per orientare la riflessione?
Certo! Un percorso che è stato (ed è ancora) entusiasmante! Teologia nella postumanità nasce da una convinzione profonda: la teologia ha ancora molto da dire sull’essere umano, soprattutto in un tempo in cui la persona è in fase di ridefinizione sotto tanti punti di vista. Dopo un primo lavoro sulla dimensione antropologica dell’Ascensione come cifra teologica dell’umano in cammino verso la pienezza (Pienezza, TAU 2022), mi sono confrontato con due teologi contemporanei – Giovanni Ancona e Mario Bracci – e grazie a loro ho realizzato quanto sia attuale l’urgenza di misurarmi con le narrazioni culturali, tecniche e scientifiche che oggi promettono un “oltre” all’umano. L’interesse per il postumano e il transumano è nato quindi da una necessità di pensiero critico per abitare il presente.
I riferimenti sono stati poi molteplici. Ho interrogato personalmente alcuni filosofi e teologi, ho organizzato dibattiti e ho viaggiato partecipando a diversi convegni per individuare i sentieri e i filoni da indagare. Oltre a questi incontri, ho poi dedicato giornate intere in biblioteca per lo studio più approfondito con tante altre pensatrici e pensatori. Giusto per elencare qualche nome: filosofi come Donna Haraway, Rosi Braidotti, Luciano Floridi; teologi come Giorgio Bonaccorso, Paolo Benanti, Giuseppe Tanzella Nitti, Rosemary Radford Ruether; pensatori come Pierre Teilhard de Chardin, che già a metà Novecento anticipava il rapporto tra evoluzione e spiritualità; docenti di università italiane e pontificie come Giovanni Salmeri, Paolo Trianni e Tiziano Tosolini. E, naturalmente, i testi del Concilio Vaticano II. Sono particolarmente legato all’eredità della Gaudium et Spes e poi ai magisteri recenti di papa Benedetto XVI e papa Francesco, entrambi consapevoli del cambiamento d’epoca e della necessità di una teologia capace di discernere i segni dei tempi.
2. Rispetto ai maestri e ai testi che ti hanno indirizzato, puoi dire di aver aggiunto qualche prospettiva nuova o qualche intuizione originale al dibattito sulla teologia della tecnologia e nel rapporto teologia-transumanesimo?
Spero di aver contribuito in due direzioni principali. La prima è una proposta antropologica che si fonda sulle parole chiave di agape e vocazione: l’umano non è solo il risultato di un’auto-programmazione o di una selezione evolutiva, ma è una chiamata a essere in relazione, a compiersi nell’incontro con l’altro e con l’Altro. Poiché l’a/Altro (sia con la minuscola, sia con la maiuscola) è un appello al soggetto a entrare in contatto con il volto, la storia, le speranze, i destini, allora credo che le categorie di prossimità, fraternità e relazionalità come insegnate dal Vangelo siano fondanti per quelle relazioni che vogliano dirsi “umanizzanti”. Al contrario, senza queste, ma anche senza la carità e senza la scoperta che la vocazione è un intreccio di chiamate nella vita, credo che il presente e il futuro posthuman saranno “disumanizzanti”.
La seconda è di tipo escatologico: molte visioni transumaniste sono animate da un’escatologia, cioè da un desiderio di compimento eterno, che più autori ormai definiscono “impropria”. Si tratta, cioè, di quel sogno di immortalità e pienezza di vita che è stato abbassato a tensioni immanenti e quindi il soggetto è ridotto a insieme di dati, backup di coscienza, sopravvivenza tecnica. La proposta cristiana non nega il desiderio di vita piena, ma lo orienta verso la riscoperta di una dimensione dell’esistenza umana fondata nella fedeltà d’amore del Creatore, piuttosto che nello sforzo prometeico del singolo. La donna e l’uomo, chiamati a relazione speciale dall’amore che li ha creati, trovano più autenticità di vita nella comunione con questo amore, piuttosto che nella frammentazione della realtà. Nel libro cerco, quindi, di rilanciare l’escatologia come chiave critica e propositiva: la speranza cristiana è un fondamento solido di vita perché ciò che la sorregge è la fedeltà della mano di Dio che ha chiamato all’esistenza tutto ciò che è.
3. E su quelli del futuro cosa immagini? Come vedi la post-umanità tra 50 o 100 anni?
Non ho pretese profetiche, ma alcune tendenze sono già visibili. La commistione tra umano e macchina continuerà. Vedremo sviluppi sempre più avanzati nell’integrazione di intelligenze artificiali nei processi cognitivi e decisionali. Alcuni scenari, come il caricamento della coscienza su supporti non biologici, oggi appaiono come fantascienza, ma sono già oggetto di ricerca (si pensi al mind uploading). Credo però che ci siano limiti ontologici che la tecnica, per quanto potente, non potrà superare, poiché la coscienza non è riducibile a informazione (con buona pace delle teorie informazionali e dataiste).
Tra i guadagni dell’epoca postumana, invece, auspico che possano crescere una maggiore consapevolezza dell’interdipendenza, un’attenzione più radicale alla fragilità e la possibilità di cure più avanzate e realmente alla portata di tutti. Mi permetto di dire “realmente alla portata di tutti” perché un nuovo segno discriminatorio già davanti agli occhi di tutti è la nuova forma di povertà che divide l’umanità in connessi e disconnessi, tecnologicamente avanzati e non, gestori delle risorse e popoli immiseriti e sfruttati a causa delle risorse stesse. Tra i pericoli, quindi, elencherei: la perdita del senso della creaturalità e finitudine, l’abbassamento del valore della relazione corporea e la costruzione di nuove forme di disuguaglianza “tecnica”. Spiritualità e teologia, a mio avviso, sono chiamate a discernere queste tensioni con lucidità.
4. Tentando di sintetizzare in brevi formule il messaggio del libro, cosa diresti?
Provo a darti due slogan, anche se sono frasi che, pur condensando le idee di fondo, non si trovano esattamente così nel testo:
- Non siamo semplicemente dati da elaborare, ma volti da amare.
- La tecnica può potenziare la vita, ma solo l’agape la trasfigura verso la pienezza.
5. Curi un bel sito web BeeBlaLo.com. Ce ne vuoi parlare?
BeeBlaLo nasce come spazio di condivisione. Il nome è giocoso. È nato durante i mesi del confinamento da Covid, mentre cercavo un termine che potesse richiamare l’onomatopea del “bla bla” alla quale unire il lavoro laborioso. Così ho pensato all’ape (da cui “Bee”) e poi giocando con vocali e consonanti il “bla bla” è diventato un “Bla” con un “Lo” finale per rimandare all’azione del parlare. Lo spirito del sito è sia leggero, che serio: offrire contenuti legati al commento della Scrittura con profondità, intelligenza e leggerezza. È uno dei modi con cui provo a rendere accessibile la teologia al di fuori delle aule fisiche, approfittando della rete come di una super-aula virtuale. Dato che i contenuti sono scritti da me negli intervalli di tempo tra le varie ricerche oppure per delle occasioni particolari, non ho scadenze fisse. E poi ho scelto la libertà di non avere finanziatori ai quali rendere conto perché la Parola di Dio è un dono gratuito e non posso sottomettere una risorsa digitale ai capricci del mercato. Quindi, la mia speranza è che possa essere uno strumento semplice, libero e accessibile… e che magari possa ispirare nella condivisione a propria volta tanti altri credenti ben preparati.



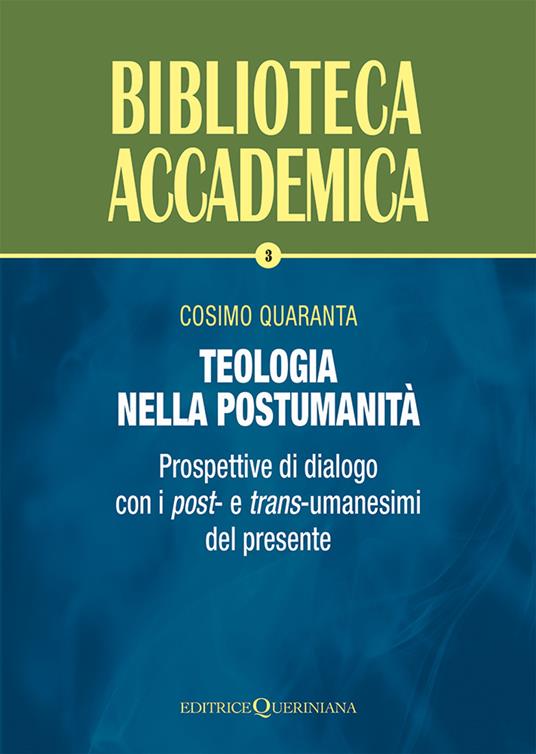


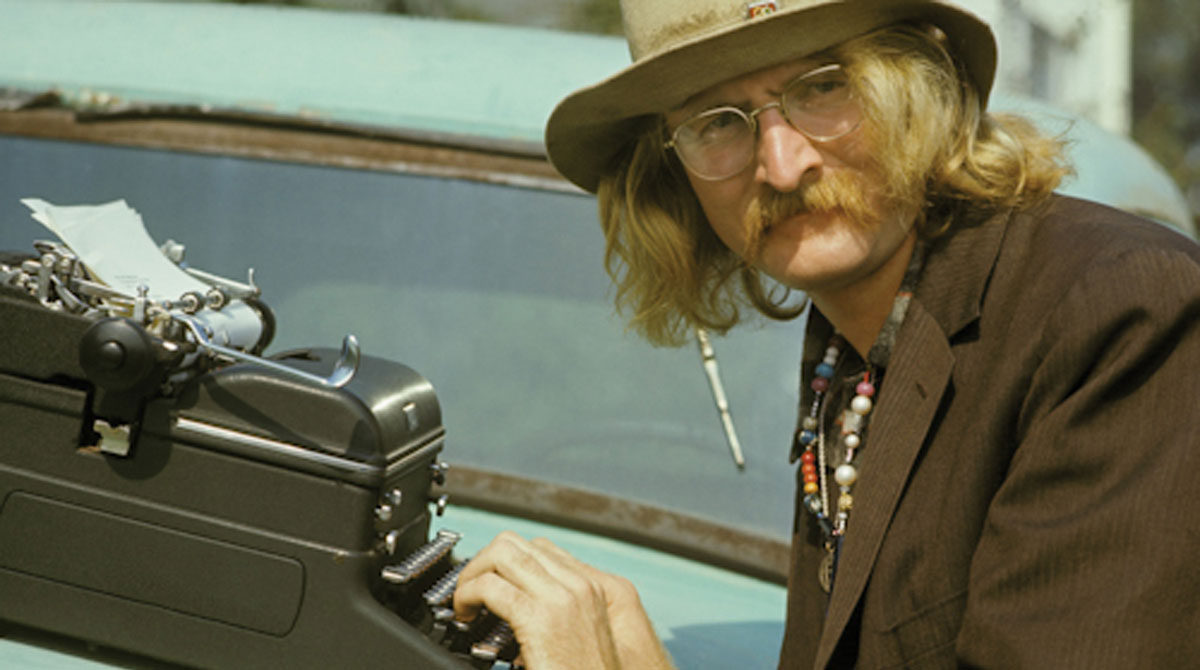
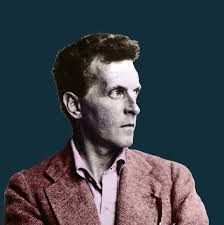
Lascia un commento