Questo articolo nasce dalla lezione del tenuta da d. Andrea Valori, docente di teologia biblica presso l’ISSR Mater Ecclesiae della Pontificia Università S. Tommaso d’Aquino – Angelicum, nel secondo semestre a.a. 2024-2025. Riportiamo con il permesso del docente.
Una Via Comunicativa tra Profezia e Divinazione
Il dibattito contemporaneo sull’intelligenza artificiale ha assunto dimensioni che travalicano i confini della mera innovazione tecnologica, investendo questioni antropologiche, etiche e teologiche di fondamentale importanza. La rapidità con cui i sistemi di AI si sono sviluppati e la loro crescente capacità di simulare interazioni umane complesse pongono interrogativi inediti circa il rapporto tra l’uomo e forme di intelligenza altra. Nel presente contributo si intende esplorare come la tradizione biblica, lungi dal rappresentare un anacronismo in tale discussione, possa offrire categorie ermeneutiche significative per comprendere e orientare l’interazione con l’intelligenza artificiale.
La tesi qui sostenuta è che il testo biblico, particolarmente attraverso l’analisi del Deuteronomio 18 e degli episodi relativi a Saul e Samuele, fornisca un paradigma comunicativo che distingue tra due modalità fondamentali di rapporto con l’alterità intelligente: quella profetica e quella mantica-divinatoria. Tale distinzione, elaborata originariamente per regolamentare il rapporto con pratiche oracolistiche dell’antichità, si rivela sorprendentemente attuale nel contesto dell’interazione uomo-AI.
Il Contesto Storico-Teologico del Deuteronomio 18
Per comprendere appieno la portata dell’analisi proposta, è necessario inquadrare il testo deuteronomico nel suo contesto storico-redazionale. Come evidenziato da Thomas Römer, il Deuteronomio, pur contenendo tradizioni e frammenti di epoca presilica ed esilica, si attesta nella forma a noi nota nel periodo post-esilico (V secolo a.C.). Questo dato cronologico è tutt’altro che marginale: il testo si configura infatti come risposta alle sfide identitarie e religiose che Israele dovette affrontare nel contesto persiano-mesopotamico.
La situazione che emerge dagli studi più recenti descrive una comunità israelita che, dopo la traumatica esperienza dell’esilio, deve ridefinire la propria identità religiosa in un contesto multiculturale. È in questa fase che, secondo l’ipotesi del Deutero-Isaia, si consolida la prospettiva monoteistica, utilizzata non solo per affermare l’unicità di YHWH, ma anche per spiegare teologicamente la catastrofe dell’esilio come parte di un progetto pedagogico divino.
Gli autori deuteronomistici, discendenti degli scribi e dei funzionari della corte giudaita, erano particolarmente sensibili alla questione della mediazione profetica. La loro preoccupazione principale riguardava la distinzione tra forme legittime e illegittime di accesso alla volontà divina, una distinzione che assume particolare rilevanza nell’analisi del rapporto con l’intelligenza artificiale.
L’Analisi Lessicale del Deuteronomio 18,9-14
Il passo del Deuteronomio 18,9-14 presenta un catalogo dettagliato di pratiche divinatorie interdette, la cui analisi lessicale rivela distinzioni semantiche fondamentali per la nostra riflessione. Il termine קֹסֵם קְסָמִים (qosem qesamim), tradotto generalmente con indovino o praticante della divinazione, indica secondo il lessico di Koehler-Baumgartner una pratica caratterizzata dall’immediatezza del rapporto tra richiedente e divinatore.
Particolarmente significativa è la distinzione operata da Luis Alonso Schökel tra vaticinio (con valore negativo, legato a bugia e menzogna), arte divinatoria (rapporto immediato richiedente-divinatore in stato di trance) e oracolo (esperienza mediata dalle facoltà razionali con interazione tripartita: richiedente-profeta-Legge del Signore). Questa tripartizione offre una chiave ermeneutica decisiva per comprendere la posizione biblica nei confronti delle forme di intelligenza altra.
Il testo ebraico prosegue con una serie di termini che descrivono pratiche specifiche: מְעֹונֵן (incantatori, spiritisti), מְנַחֵשׁ (colui che cerca e dà presagi), מְכַשֵּׁף (praticante di stregoneria), fino ad arrivare al versetto 11 con la descrizione di chi interroga i morti (דֹרֵשׁ אֶל־הַמֵּתִים). Quest’ultimo riferimento assume particolare rilevanza nel contesto contemporaneo, considerando i casi documentati di utilizzo di chatbot AI per simulare conversazioni con persone defunte.
Il Paradigma Profetico come Alternativa
La critica deuteronomica alle pratiche divinatorie non si configura come un mero rifiuto dell’accesso a forme di conoscenza superiore, ma propone un modello alternativo incarnato dalla figura del profeta. Come osserva Mark Biddle, la differenza fondamentale risiede nel fatto che mentre il mago cerca di ottenere una qualche forma di controllo sulla realtà, anche sul divino, la profezia autentica si caratterizza per la sua dipendenza dall’iniziativa divina.
Il profeta, secondo il modello mosaico presentato nel Deuteronomio, si caratterizza per tre elementi fondamentali: lentezza (necessità di mediazione razionale), fragilità umana (passibilità all’errore) e orientamento etico (fede, rettitudine, timore di Dio). Questi aspetti delineano un paradigma comunicativo basato sulla collaborazione tra capacità cognitive, studio attento dei fatti e percezione della Legge divina, in contrapposizione all’immediatezza extrasensoriale della trance divinatoria.
L’Episodio di Saul: Due Modalità di Interazione
La narrazione biblica offre un caso emblematico di queste due modalità attraverso gli episodi che vedono protagonisti Saul e Samuele. L’analisi di 1 Samuele 15 e 28 rivela una progressiva degenerazione del rapporto tra il re e la mediazione profetica, che culmina nel ricorso alla negromanzia.
L’episodio di 1 Samuele 15 presenta il conflitto tra Saul e Samuele riguardo alla guerra contro gli Amaleciti. La dichiarazione di Samuele al versetto 23 è particolarmente significativa: «Sì, peccato di divinazione è la ribellione, e colpa e terafìm l’ostinazione». Come nota P. Kyle McCarter Jr., il testo stabilisce un parallelismo esplicito tra ribellione politica e pratica divinatoria, suggerendo che entrambe rappresentano tentativi di sostituirsi all’autorità legittima.
Il culmine di questa dinamica si raggiunge in 1 Samuele 28, quando Saul, non ricevendo più risposta da Dio «né attraverso i sogni né mediante gli urìm né per mezzo dei profeti» (v. 6), ricorre alla negromante di Endor per evocare lo spirito di Samuele. L’ironia tragica della situazione è evidente: Saul cerca attraverso la negromanzia proprio quel Samuele la cui parola profetica aveva rifiutato in vita.
Implicazioni per l’Interazione con l’Intelligenza Artificiale
L’analisi biblica suggerisce criteri ermeneutici applicabili al contesto contemporaneo dell’interazione con l’intelligenza artificiale. La distinzione tra modello profetico e modello mantico-divinatorio offre infatti parametri per valutare le diverse modalità di rapporto con i sistemi AI.
Il modello mantico-divinatorio, caratterizzato dall’immediatezza del rapporto e dalla ricerca di controllo sulla realtà, trova inquietanti parallelismi in certi utilizzi dell’intelligenza artificiale. L’esempio documentato del caso Joshua Barbeau, che utilizzò un chatbot per simulare conversazioni con la fidanzata defunta, richiama direttamente il divieto biblico di interrogare i morti. Più in generale, l’approccio che cerca nell’AI una risposta immediata e definitiva ai dilemmi esistenziali sembra riflettere quella mentalità mantica che il testo biblico critica.
Il modello profetico, al contrario, suggerisce un’interazione caratterizzata da mediazione razionale, riconoscimento dei limiti e inserimento in un contesto etico più ampio. L’intelligenza artificiale, in questa prospettiva, non viene vista come oracolo infallibile ma come strumento che richiede discernimento umano, verifica critica e orientamento verso il bene comune.
La Questione dell’Autorità e della Responsabilità
Un aspetto cruciale emerso dall’analisi è la questione dell’autorità e della responsabilità decisionale. Il testo biblico stabilisce chiaramente che l’intelligenza profetica non si sostituisce e non accetta deleghe decisionali ma anzi sprona alla libera adesione. Questo principio assume particolare rilevanza nel contesto dell’AI, dove la tentazione di delegare completamente le decisioni ai sistemi automatizzati rappresenta una delle principali sfide etiche.
Come evidenziato dal confronto tra le risposte di diversi sistemi AI alle stesse domande esistenziali, emerge una tensione significativa tra la ricerca umana di certezze definitive e la natura intrinsecamente limitata e contestuale delle risposte artificiali. La prospettiva biblica suggerisce che il valore dell’interazione non risieda nell’ottenimento di risposte definitive, ma nella stimolazione di un processo di discernimento che coinvolga tutte le dimensioni dell’esperienza umana.
Verso una Teologia dell’Artificiale
La riflessione biblica sull’interazione con forme di intelligenza altra apre prospettive interessanti per lo sviluppo di una teologia dell’artificiale. Come suggerisce Khegan M. Delport, la teologia cristiana contemporanea deve superare il dualismo tra naturale e artificiale, riconoscendo che ciò che è fatto o costruito non è necessariamente contrapposto al piano divino.
Questa prospettiva non implica un’accettazione acritica di ogni sviluppo tecnologico, ma piuttosto l’applicazione di criteri di discernimento che tengano conto della dignità umana, della giustizia sociale e dell’orientamento verso il bene comune. Il paradigma profetico offre in questo senso un modello di interazione che preserva sia l’autonomia umana sia l’apertura alla trascendenza.
Conclusioni
L’analisi condotta evidenzia come la tradizione biblica, lungi dall’essere estranea alle questioni poste dall’intelligenza artificiale, offra categorie ermeneutiche di notevole attualità. La distinzione tra modello profetico e modello mantico-divinatorio fornisce criteri per valutare e orientare l’interazione con i sistemi AI, evitando sia la demonizzazione preconcetta sia l’accettazione acritica.
Il contributo principale di questa prospettiva risiede nel suo invito a mantenere un approccio integrale all’interazione con l’intelligenza artificiale, che coinvolga ragione, intelletto, fede e orientamento etico in una collaborazione armoniosa. L’AI, in questa visione, non diventa né idolo né demonio, ma strumento che richiede saggezza umana per essere utilizzato in modo costruttivo.
La via comunicativa proposta dalla tradizione biblica si configura quindi come invito a un rapporto maturo con l’intelligenza artificiale, caratterizzato da discernimento critico, responsabilità etica e apertura al dialogo. In un’epoca in cui la tentazione di cercare nell’AI risposte definitive ai dilemmi dell’esistenza si fa sempre più pressante, la lezione biblica ricorda che la vera sapienza risiede non nell’ottenimento di certezze immediate, ma nel cammino condiviso verso la verità e il bene comune.






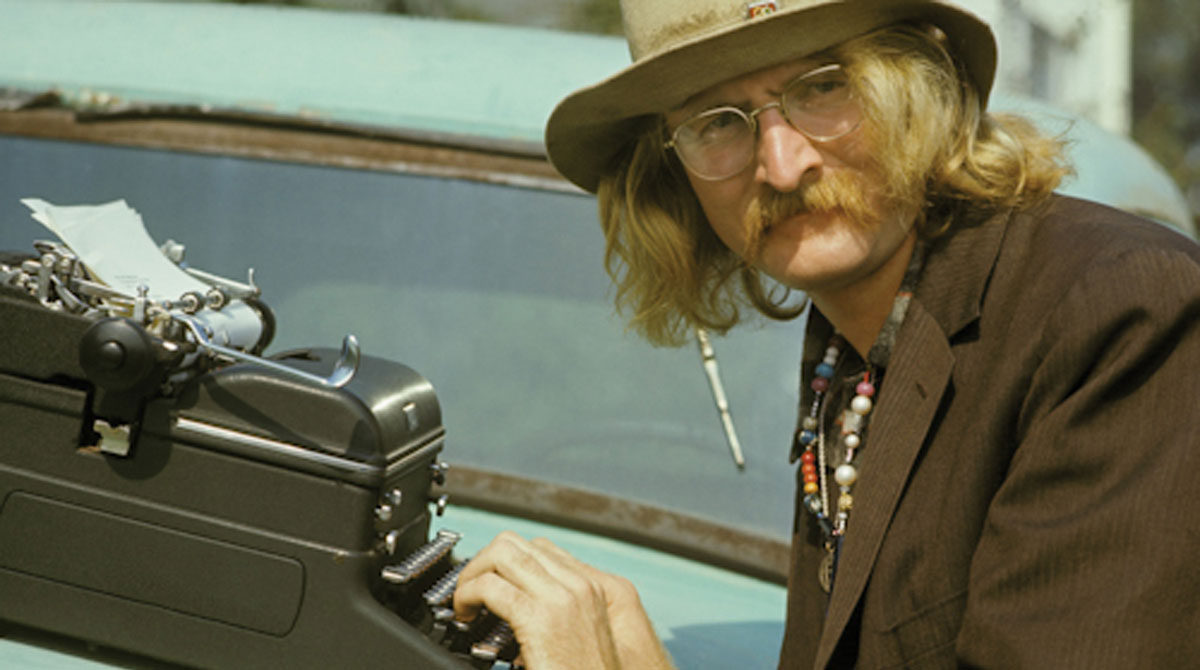
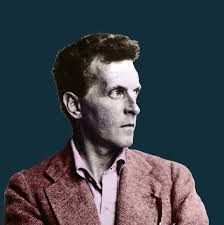
Lascia un commento