L’idea tradizionale di algoritmo lo descrive come un elenco di istruzioni dettagliate, progettate per svolgere un’attività o risolvere un problema specifico. L’esempio classico della ricetta di una torta è emblematico: seguendo i passi, si ottiene il risultato atteso. In questa visione, l’algoritmo è deterministico.
Questa concezione classica è stata sovvertita dall’avvento dell’IA basata sul machine learning. Oggi, l’algoritmo non fornisce più un risultato deterministico, ma – in base ai dati di addestramento e al profilo dell’utente – genera esiti differenziati persino per input identici.
Questa capacità trasformativa ha un impatto sociale profondo: gli algoritmi non si limitano a suggerire contenuti (streaming), notizie (siti d’informazione) o prodotti (e-commerce), ma contribuiscono a plasmare idee, tendenze e percezioni collettive.
La sociologia ha recentemente avviato un ripensamento radicale del ruolo dell’IA, investigando come gli algoritmi apprendano da un mondo sempre più datificato. Tre sociologi italiani hanno esplorato questa rivoluzione da angolature complementari, offrendo nelle loro opere una rilettura del ruolo socioculturale degli algoritmi.
Proponiamo le recensioni di queste tre opere:
- Machine Habitus. Sociologia degli algoritmi (Il Mulino, 2023) di Massimo Airoldi;
- Comunicazione artificiale. Come gli algoritmi producono intelligenza sociale (Bocconi University Press, 2022) di Elena Esposito;
- Intelligenza artificiale sociale (Rubbettino, 2025) di Vanni Rinaldi.
Elena Esposito, Comunicazione artificiale. Come gli algoritmi producono intelligenza sociale
Bocconi University Press, 2022, pp.256, € 20,90 (ebook € 14,99)
Elena Esposito, con Comunicazione artificiale. Come gli algoritmi producono intelligenza sociale (2022, Egea), offre una riflessione teorica audace e profondamente originale sul ruolo degli algoritmi nella società contemporanea, indagando non tanto il loro funzionamento tecnico quanto la loro capacità di generare nuove forme di intelligenza sociale attraverso processi comunicativi automatizzati. Muovendosi oltre le tradizionali opposizioni tra umano e artificiale, Esposito propone una tesi radicale: gli algoritmi non si limitano a elaborare dati, ma producono comunicazione, contribuendo attivamente alla costruzione della realtà sociale. Il libro si inserisce nel solco della teoria dei sistemi sociali di Niklas Luhmann, di cui Esposito è tra le maggiori interpreti contemporanee, ma la sviluppa in modo innovativo per affrontare la sfida dell’intelligenza artificiale.
Per comprendere la svolta concettuale proposta da Esposito, è essenziale chiarire le fondamenta luhmanniane su cui costruisce la sua analisi. Niklas Luhmann rivoluziona la sociologia classica proponendo che la società non sia composta da individui o azioni soggettive, bensì da comunicazioni. Queste comunicazioni formano sistemi sociali autopoietici – entità autoreferenziali che si auto-riproducono selezionando e collegando informazioni secondo logiche interne. «Un sistema sociale esiste solo quando si realizza una comunicazione che ne richiama un’altra, in una catena di selezioni che si auto-alimenta» (Luhmann, Sistemi sociali, 1984).
Esposito applica questo quadro all’ecosistema algoritmico: gli algoritmi non sono meri elaboratori di input, ma sistemi operativi chiusi che generano comunicazione attraverso tre atti inscindibili:
- Selezione dell’informazione (es.: un algoritmo di raccomandazione identifica pattern nei dati);
- Enunciazione (produce un output: “Le persone come te hanno acquistato Y”);
- Comprensione (l’utente reagisce, innescando nuove comunicazioni).
Questa tripartizione spiega la tesi centrale del libro:
Gli algoritmi non elaborano semplicemente dati; producono comunicazione. […] Generano selezioni (informazione) che suscitano selezioni successive (reazioni degli utenti, altri algoritmi), innescando catene comunicative autonome (p. 48).
La comunicazione artificiale emerge così come un processo impersonale e autoreferenziale, svincolato dall’intenzionalità umana ma capace di generare intelligenza sociale attraverso la creazione di contesti di significato, aspettative e memorie collettive.
La potenza teorica di Esposito si manifesta nell’analisi di come questa comunicazione algoritmica generi intelligenza sociale distribuita. Nei motori di ricerca o nei sistemi predittivi, gli algoritmi non si limitano a prevedere comportamenti ma li costituiscono attraverso profezie auto-avveranti: la raccomandazione “chi ha visto X ha visto anche Y” crea un’aspettativa normativa che orienta le scelte individuali. Parallelamente, gli algoritmi gestiscono una memoria operativa che decide cosa conservare e cosa dimenticare (si pensi al diritto all’oblio), riorganizzando le tracce digitali secondo logiche presenti: «L’algoritmo non ricorda i fatti, ma le tracce che lasciano, e le riorganizza in base a logiche presenti» (p. 112). Questa dinamica crea una paradossale fiducia sistemica in sistemi opachi (black box), simile a quella accordata a istituzioni astratte come il denaro o il diritto.
La profondità dell’analisi di Esposito emerge dal serrato dialogo con le principali tradizioni sociologiche e filosofiche. La base è naturalmente Niklas Luhmann, la cui teoria della comunicazione come operazione autoreferenziale viene radicalizzata per mostrare come gli algoritmi realizzino concretamente l’autonomia dei sistemi sociali. Tuttavia, Esposito arricchisce questo impianto con contributi esterni: dalla filosofia della tecnica di Gilbert Simondon mutua il concetto di individuazione tecnica, utile a pensare gli algoritmi come processi in divenire piuttosto che entità statiche.
Un confronto critico è istituito con Antoinette Rouvroy e la sua analisi della governabilità algoritmica: se Rouvroy enfatizza la datificazione come strumento di controllo, Esposito ne contesta il determinismo, sottolineando invece la produttività comunicativa degli algoritmi nel generare intelligenza sociale. Allo stesso modo, mentre Luciana Floridi sviluppa la nozione di inforg (ibridi info-organici) per descrivere l’interazione uomo-algoritmo, Esposito ne trascende l’approccio individualista, insistendo sulla dimensione sistemica e impersonale della comunicazione artificiale.
La discussione con Shoshana Zuboff e la sua teoria del capitalismo della sorveglianza è particolarmente significativa: Esposito riconosce la validità dell’analisi dello sfruttamento dati, ma sposta l’attenzione verso la capacità degli algoritmi di generare valore cognitivo attraverso la partecipazione ai processi comunicativi.
Il contributo decisivo di Esposito risiede nell’aver sintetizzato queste prospettive in un quadro teorico coerente che eleva la comunicazione artificiale a categoria sociologica fondamentale, analoga a concetti come lavoro per le società industriali. La sua analisi mostra come gli algoritmi siano meccanismi operativi che ridefiniscono la natura stessa del sociale.
La forza del libro risiede nel rigore teorico con cui Esposito decostruisce categorie antropocentriche, mostrando come gli algoritmi generino intelligenza sociale attraverso logiche impersonali. L’interdisciplinarità – che fonde sociologia, filosofia e scienza dell’informazione – offre strumenti innovativi per pensare la complessità algoritmica.
Tuttavia, emergono alcune questioni critiche:
- La dimensione del potere rimane sfumata nell’approccio sistemico. Come conciliare l’autonomia della comunicazione artificiale con il controllo oligopolistico delle Big Tech su dati e infrastrutture?
- La materialità concreta (server, consumo energetico, catene globali di produzione) è trascurata a favore dell’analisi operativa.
- La normatività implicita: se gli algoritmi producono intelligenza sociale, con quali criteri valutarne gli esiti distorsivi (bias, disinformazione)?
Comunicazione artificiale rappresenta una pietra miliare per la sociologia degli algoritmi. Elena Esposito non si limita a descrivere impatti sociali, ma ridefinisce l’oggetto stesso della disciplina, mostrando come la comunicazione algoritmica sia ormai un meccanismo costitutivo della società contemporanea. In dialogo con Airoldi (che analizza gli algoritmi attraverso l’habitus bourdieusiano), Esposito ci costringe a ripensare la nozione di sociale in un’epoca di mediazione algoritmica. Come afferma nell’ultima pagina: «Il problema non è se gli algoritmi diventeranno intelligenti, ma come stiamo già diventando sociali con loro e attraverso di loro» (p. 221). Testo imprescindibile per chi voglia affrontare con strumenti teorici all’altezza la sfida della società algoritmica.



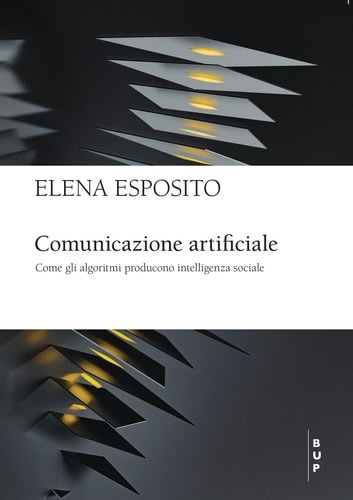
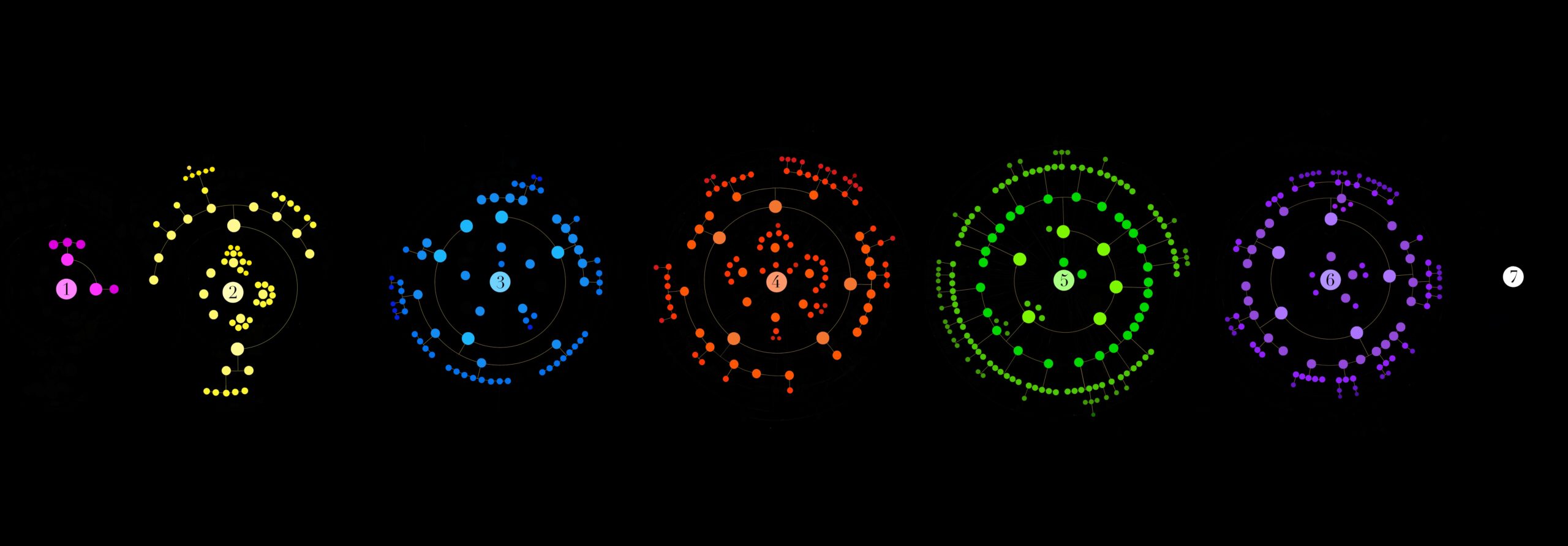



Lascia un commento