L’idea tradizionale di algoritmo lo descrive come un elenco di istruzioni dettagliate, progettate per svolgere un’attività o risolvere un problema specifico. L’esempio classico della ricetta di una torta è emblematico: seguendo i passi, si ottiene il risultato atteso. In questa visione, l’algoritmo è deterministico.
Questa concezione classica è stata sovvertita dall’avvento dell’IA basata sul machine learning. Oggi, l’algoritmo non fornisce più un risultato deterministico, ma – in base ai dati di addestramento e al profilo dell’utente – genera esiti differenziati persino per input identici.
Questa capacità trasformativa ha un impatto sociale profondo: gli algoritmi non si limitano a suggerire contenuti (streaming), notizie (siti d’informazione) o prodotti (e-commerce), ma contribuiscono a plasmare idee, tendenze e percezioni collettive.
La sociologia ha recentemente avviato un ripensamento radicale del ruolo dell’IA, investigando come gli algoritmi apprendano da un mondo sempre più datificato. Tre sociologi italiani hanno esplorato questa rivoluzione da angolature complementari, offrendo nelle loro opere una rilettura del ruolo socioculturale degli algoritmi.
Proponiamo le recensioni di queste tre opere:
- Machine Habitus. Sociologia degli algoritmi (Il Mulino, 2023) di Massimo Airoldi;
- Comunicazione artificiale. Come gli algoritmi producono intelligenza sociale (Bocconi University Press, 2022) di Elena Esposito;
- Intelligenza artificiale sociale (Rubbettino, 2025) di Vanni Rinaldi.
Massimo Airoldi, Machine Habitus. Sociologia degli algoritmi
Il Mulino, Collana Koiné, 2023, pp.178, € 21,00 (ebook € 11,99)
Nel panorama italiano della sociologia digitale, il volume di Massimo Airoldi Machine Habitus. Sociologia degli algoritmi rappresenta un contributo originale e necessario. Pubblicato nel 2023 da Il Mulino, il testo si inserisce nella crescente letteratura che indaga le forme di potere algoritmico e le logiche di funzionamento dei sistemi di raccomandazione e profilazione automatica. Tuttavia, ciò che distingue Machine Habitus è l’adozione esplicita di un quadro concettuale bourdieuiano, che consente ad Airoldi di proporre una riformulazione teorica e metodologica di come comprendere la co-produzione sociale dei dati e delle tecnologie algoritmiche.
Il titolo del libro gioca volutamente con il concetto cardine di Pierre Bourdieu: l’habitus, inteso come sistema di disposizioni incorporate che guida le pratiche individuali all’interno di determinati campi sociali. Airoldi introduce l’idea di un machine habitus, ovvero un insieme di schemi algoritmici che agiscono nel modellare e classificare i comportamenti umani a partire da grandi quantità di dati. Il termine, lungi dall’essere una semplice metafora, viene articolato con rigore concettuale: «gli algoritmi di profilazione non si limitano a rispecchiare le abitudini degli utenti, ma partecipano attivamente alla loro costruzione e cristallizzazione» (p. 23).
Questa visione si distanzia nettamente da due approcci ancora diffusi: da un lato, l’idea ingenua dell’algoritmo come “scatola nera” neutrale, mera esecutrice di istruzioni; dall’altro, un certo determinismo tecnologico che attribuisce ai sistemi digitali una potenza quasi totalizzante. In entrambi i casi, si perde di vista la natura sociale, storica e contestuale della tecnologia. Airoldi, al contrario, propone una sociologia che assume gli algoritmi come «forme strutturate di visione e divisione del mondo», che si radicano nelle dinamiche di classe, gusto e distinzione tipiche della modernità tardo-capitalista.
Tra i casi empirici discussi, uno spazio importante è riservato ai sistemi di raccomandazione impiegati nelle piattaforme digitali (Netflix, Spotify, Amazon, TikTok). Airoldi mostra come tali sistemi operino una traduzione delle preferenze individuali in classificazioni algoritmiche che, pur presentandosi come personalizzate, si basano su modelli probabilistici e su inferenze che tendono a riprodurre schemi di consumo già sedimentati.
In questo senso, il machine habitus non è solo una tecnologia, ma una forma di categorizzazione strutturata, che interagisce con le disposizioni sociali degli utenti, generando forme di retroazione (feedback loops).
Il merito teorico maggiore del volume consiste nell’estensione creativa del pensiero di Bourdieu agli ambienti digitali. Airoldi recupera non solo l’idea di habitus, ma anche quelle di campo, capitale simbolico e classificazione. Gli algoritmi, in questo quadro, non sono meri strumenti, ma agenti classificatori che operano all’interno di campi specifici (il mercato culturale, l’ambiente digitale, la pubblicità, ecc.), in cui attori umani e non umani si contendono risorse simboliche.
L’autore si mostra consapevole dei rischi insiti in una simile trasposizione: non si tratta di attribuire agency in senso pieno alle macchine, ma di riconoscere la loro funzione strutturante all’interno di reti socio-tecniche complesse. Come scrive: «non sono le macchine a possedere un habitus in senso stretto, ma è possibile identificare nelle loro operazioni regolarità e schemi d’azione che ne mimano le funzioni» (p. 47).
A questa prospettiva contribuiscono anche gli studi della sociologia della traduzione (Callon, Latour) e della Actor-Network Theory, benché Airoldi adotti una posizione più strutturalista rispetto al relativismo simmetrico di Latour. È interessante notare come il testo stabilisca un dialogo anche con le riflessioni più recenti sull’automazione sociale, come quelle di Shoshana Zuboff (2019) e di Antoinette Rouvroy, in particolare sul concetto di governamentalità algoritmica(algorithmic governmentality).
Il volume si distingue anche per l’attenzione alla metodologia, combinando analisi qualitativa, etnografia digitale e data analysis. Airoldi insiste sull’importanza di una sociologia computazionale riflessiva, che non abdichi alla propria tradizione critica di fronte alla mole di dati generati dalle piattaforme. In tal senso, il libro si colloca nel solco di autori come Bruno Latour, ma anche di studiosi italiani come Giovanni Boccia Artieri e Paolo Magaudda, con i quali condivide l’urgenza di un approccio teoricamente fondato e empiricamente rigoroso.
Le ricerche empiriche condotte dall’autore – ad esempio sull’uso degli hashtag su Instagram o sulla formazione delle raccomandazioni musicali – servono a dimostrare come il machine habitus contribuisca a stabilizzare forme di distinzione simbolica anche nel contesto apparentemente orizzontale delle piattaforme. Un punto chiave emerge qui: «la personalizzazione algoritmica non è un antidoto all’omologazione, ma spesso ne costituisce il vettore più potente» (p. 112).
Un possibile limite del libro – se così si può parlare – riguarda la difficoltà intrinseca di articolare fino in fondo la relazione tra habitus umano e machine habitus. Sebbene l’autore eviti ogni forma di determinismo, rimane aperta la questione della resistenza o dissonanza che gli attori sociali possono esercitare rispetto alla categorizzazione algoritmica. In questo senso, un dialogo più esplicito con le teorie della resistenza digitale avrebbe potuto arricchire ulteriormente l’analisi.
Tuttavia, il volume getta le basi per una prospettiva di lungo periodo sulla co-evoluzione tra soggetti e tecnologie di classificazione, offrendo una cornice teorica robusta e fertile per ulteriori ricerche. È auspicabile che il concetto di machine habitus venga sviluppato anche in chiave comparativa e storica, mettendolo in relazione con altre forme di razionalità classificatoria (statistica, biopolitica, tecnocrazia).
Machine Habitus è un libro denso, teoricamente ambizioso e metodologicamente solido. Esso rappresenta un tentativo riuscito di pensare in modo sociologico l’algoritmo, andando oltre tanto le visioni tecnofile quanto le retoriche allarmiste. Per chi si occupa di sociologia della tecnologia, cultura digitale o teoria sociale, il testo di Airoldi costituisce una lettura imprescindibile, capace di coniugare rigore accademico e attualità critica.
Come afferma l’autore nella conclusione: «decifrare il funzionamento degli algoritmi non basta. Occorre capire come essi riscrivano le regole del gioco sociale» (p. 151). In questo senso, Machine Habitus contribuisce a tale decifrazione, fornendo una bussola teorica per orientarsi nei territori mutevoli del capitalismo digitale.



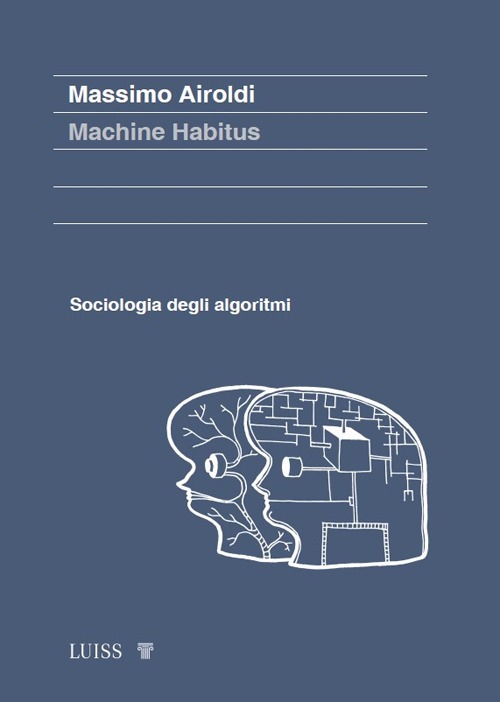
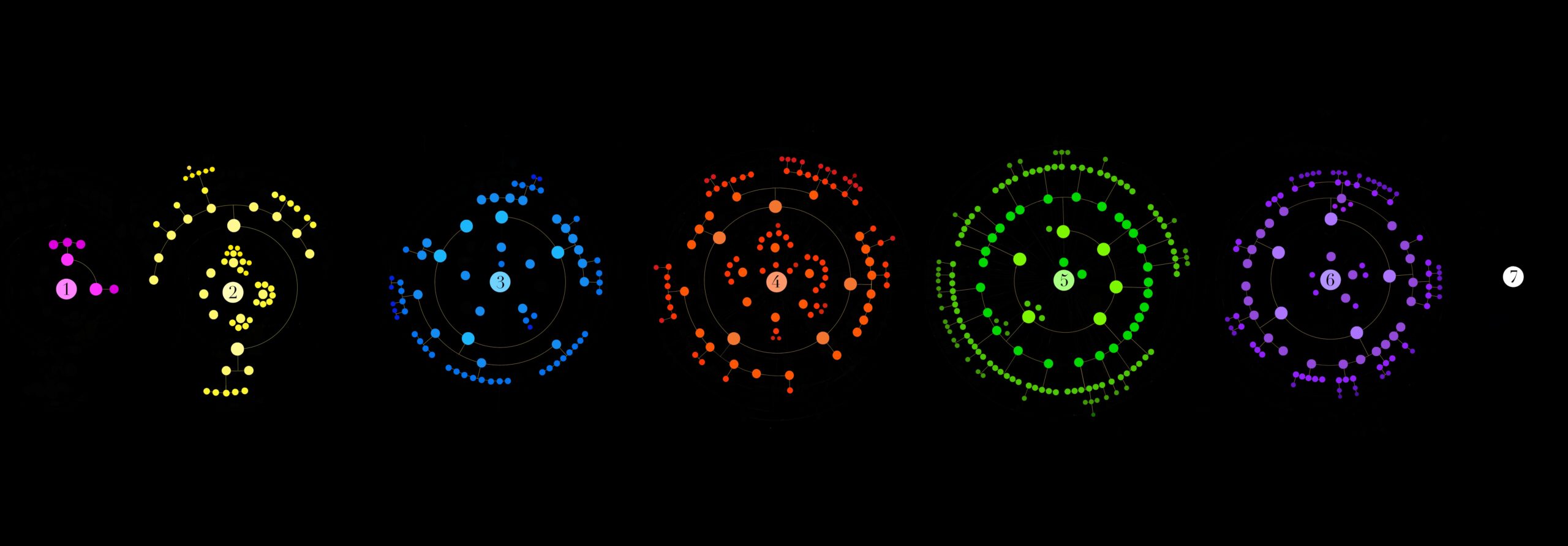



Lascia un commento